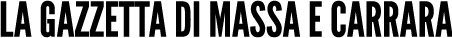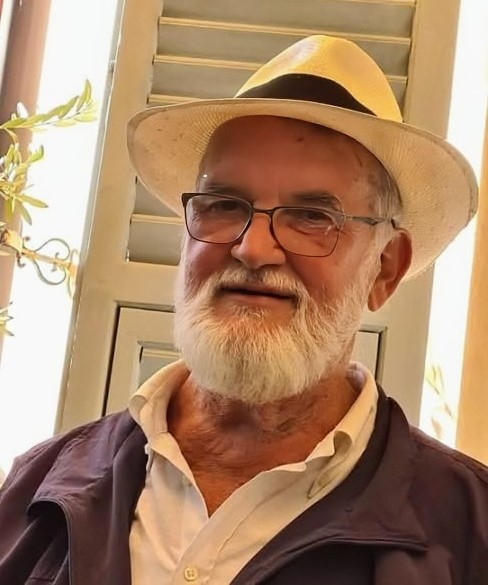Un'altra data del tour di presentazione del libro "Ciel sereno, terra scura. Racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato" di Riccardo Boggi. L'appuntamento è per il 20 luglio alle ore 18 a Tavernelle. L'autore, già dirigente del Settore Cultura del Comune di Aulla e profondo conoscitore della storia locale, torna a parlare della Lunigiana e delle sue intricate vicende storiche, culturali e sociali, attraverso un libro che ripropone alcune pagine della sua tesi di laurea discussa a Genova nel 1975.Boggi ci conduce in un viaggio affascinante alla scoperta di una terra dalle mille contraddizioni storiche, culturali e sociali che rendono difficile trarne un profilo unitario ed escludono ogni valutazione conclusiva: "più che tracce di particolari e ben definite epoche storiche e culturali – si legge - è riscontrabile una perenne dimensione esostorica". È un primo e significativo passaggio scritto da Boggi nell'introduzione della sua opera "Ciel sereno, terra scura. Racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato". Un luogo senza tempo, quello della Lunigiana, in cui la storia evolve in una perenne mescolanza di epoche lontane ma compresenti nelle pieghe infinite del presente: "la preistoria si estende oltre l'avvento del cristianesimo. Non è difficile vedere portali dell'Ottocento di tipo quattrocentesco e sculture tipologicamente romaniche che risalgono appena a qualche decennio fa". Negli anni Settanta Boggi descriveva una realtà socio-economica fortemente ambigua: da un lato, la progressiva decadenza dell'agricoltura che per secoli era stata la base economica della vallata e dall'altro, l'insufficiente emancipazione industriale della zona. Con lungimirante lucidità, già in quegli anni Boggi metteva in guardia sul pericolo della desertificazione del territorio: "Non esistendo alternative economiche in loco, le giovani generazioni sono costrette all'emigrazione". Un fenomeno, quello dello spopolamento, di cui Boggi intercetta la datazione agli inizi dell'Ottocento con il crollo (tardivo) dei persistenti ancoraggi feudali che reggevano le strutture socio economiche locali: è in quell'epoca che, secondo l'autore, la Lunigiana abbandona l'economia chiusa, agricola e mutualistica per orientarsi sull'economia monetaria. Ambiguità socio economiche che necessariamente impattano sulla società nelle sue abitudini culturali e nelle sue tradizioni: "Così che elementi della cultura tradizionale e contadina convivono con quelli della società di massa". Acuta l'interpretazione che l'autore dà della tribolata transizione alla società di massa della società contadina lunigianese: la persistenza di retaggi che hanno agito come valvole di sfogo in un processo che non è stato accompagnato da adeguate trasformazioni socio-economiche e che pertanto è rimasto impantanato nell'ambiguità di un modello che pesa ancor oggi, poco meno di allora. Retaggi e ritardi che con lucidità Boggi intercettava già in quegli anni settanta con una straordinaria capacità anticipatoria, suffragata da quella tipica cifra immancabile in ogni sua opera: l'osservazione storica. Quella stessa pressione della società di massa che allora agiva in Lunigiana scardinando i valori tradizionali della cultura contadina, non riusciva però ad assicurare le stesse strutture e le stesse certezze in campagna così come nelle aree urbanizzate, condannando questa terra in un limbo di temporale in cui la pratica magica rappresenta e conferma l'incompiuto trapasso alla modernità.
Un campanello sui ritardi strutturali che tutt'oggi frenano lo sviluppo della Lunigiana, analizzati facendo originalissima leva su un punto di vista inedito: il bisogno di certezze e di sicurezze che la popolazione esorcizza ma nel contempo attualizza (in parte tutt'ora, come allora) nel ricorso alla tradizione popolare delle segnature.